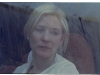Lo scrivo da subito: “La vita di Adele – Capitoli 1 & 2” di Abdellatif Kechiche (liberamente ispirato al romanzo a fumetti “Il blu è un colore caldo” di Julie Maroh) è un film distantissimo dai miei gusti, interessi o idee, ma è un grande film, ed una meritatissima Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes 2013.
E non lo è tanto per l’ambientazione o la critica alle classi intellettuali e privilegiate di Lille, quanto per l’incredibile capacità che il regista dimostra ancora una volta (vedi “L’esquive“ o “La graine et le mulet“) nel dirigere i propri interpreti, nello specifico le splendide Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos, che qui gli si concedono totalmente e letteralmente. Questo rapporto di empatia “discendente” (nel senso più etimologico del termine) tra l’autore e le protagoniste, in cui la fortissima personalità del primo va dispiegandosi e confondendosi nelle attrici, produce forse la miglior applicazione del “metodo Stanislavskij” che si sia vista al cinema negli ultimi anni. Vista la profondità e qualità delle loro interpretazioni, mi domando quanto abbiano impiegato le due giovani donne ad “uscire” dai rispettivi personaggi e dalla propria relazione, ma una cosa è certa: se l’egocentrico Kechiche è riuscito a spingerle ad un tale livello di complicità e fiducia, deve essere un fine conoscitore delle dinamiche psicologiche femminili (oppure un sadico despota come accusa la Seydoux…). Proprio in questo risiedono i recenti e tristi dissapori che hanno accompagnato l’uscita internazionale del film.
Venendo all’opera, la storia di Adele cattura non tanto per quel che le accade (banalmente: un amore), quanto per quel che cerca e le viene offerto. E cosa cerca Adele? Cosa le manca? E soprattutto, cosa trova?
Kechiche è molto attento nel definirla: Adele è una liceale immatura ed imperfetta, affine alle proprie coetanee, piena delle contraddizioni, pulsioni e pregiudizi dell’età e del genere; ha un fantastico rapporto con il cibo (quasi feticistiche le continue riprese della sua bocca) e con il proprio corpo ed è in pace con la propria famiglia e la propria classe sociale (lavoratori un po’ petit bourgeois).
Insomma è una di quelle ragazze semplici, perfettamente inserite nella “medietà” scolastica, e sociale, e politica, che non brillano certo per passione o impeto o stimolo intellettuale (però “ti ho inserito nel gruppo delle più carine della classe” le riferisce candidamente una compagna di classe).
Il suo sogno è di fare la maestra, perché “la scuola mi ha dato tanto” e perché ama i bambini.
Poi accade l’irreparabile: la visione, fugace e casuale, di una donna dai capelli blu (“La vie d’Adèle – chapitres 1 et 2 – Le bleu est une couleur chaude” è il titolo originale e completo del film) mette profondamente in discussione le sue certezze ed identità. (1)
A partire da tale visione, e dal successivo incontro con la pittrice Emma, più volte evitato ma pervicacemente cercato, Adele entra in un mondo che non aveva mai conosciuto: dove si discetta di esistenzialismo in Jean-Paul Sartre, delle opere “floreali” di Gustav Klimt o delle pose deformi di Egon Schiele, dove si citano i classici della letteratura e dove è inconcepibile che un talento artistico possa rimanere sprecato. A questo mondo ella si abbandona gioiosamente e placidamente, scoprendo la tenerezza e la delicatezza di un amore puro, e quella passione erotica inebriante e totalizzante che tanto aveva desiderato e sperimentato, con deludenti risultati, in precedenza.
È proprio nelle splendide (anche se molto “montate”) scene di sesso tra Adele ed Emma che il film raggiunge il suo picco sentimentale e narrativo: nelle imperfezioni, nell’ossessiva ricerca e nel naturale intrecciarsi dei loro corpi vi è un che di liberatorio, di pacificatorio e di spirituale; nei loro continui orgasmi una citazione del mito di Tiresia (2), la pura e semplice concretizzazione del desiderio, così distanti dal sesso conturbante e disturbante di un Lars von Trier, ad esempio.
Sarà sempre il sesso, più che le affinità, ad unirle, e via via che la relazione matura e le differenze di classe si acuiscono, passando per esperienze ed incontri non alla portata di Adele, o che per inadeguatezza rifugge, il loro amore diventerà una sorta di àncora a cui aggrapparsi e dedicarsi totalmente.
Quindi Kechiche prima suggerisce, poi evidenzia ed infine declina tutte le difficoltà insite in una relazione non paritaria, mostrando non tanto una banale crisi di amore, quanto una vera e propria apocalisse (anche qui, nel senso più etimologico del termine) sentimentale della propria eroina. Emma esce di scena, per divenire la presenza fantasmagorica di Adele.
L’ultima parte del film non la svelo, essa ricopre un periodo di circa 3 anni, nei quali da ragazza imperfetta Adele si trasforma in donna imperfetta, mantenendo intatto il proprio fascino. Talora un’imperfezione d’animo può contaminare l’intero carattere e nella nuova Adele le stigmate del passato ostacolano la sua realizzazione, che risente dell’incompiutezza di un percorso, quantomeno potenziale, che le era stato offerto.
In tale senso la vicenda si dipana nell’esatto opposto del bildungsroman (3) classico, perché l’autore franco-tunisino non fa sconti alla propria eroina, ma ad Adele ed Emma riserverà ancora una volta uno sguardo delicato con la scena più appassionata e sublime dell’intero film, che ovviamente non posso raccontare.
Infine qualche piccola annotazione tecnica: ottima scelta l’utilizzo della camera a mano e la prossimità ai soggetti, con l’insistenza di primi e primissimi piani (4). Già citate le ossessive inquadrature della bocca di Adele e del cibo in generale (povere ostriche!), altrettanto significative sono le ripetizioni di medesime pose in ambienti e situazioni differenti, a delineare lo scorrere del tempo. Le riprese a scuola e la bellezza degli studenti richiamano invece alla memoria le fantastiche sequenze del già citato “L’esquive”. In un certo senso si può dire che la scrittura visiva di Kechiche sia più che intima, al limite dell’impudico, quasi pornografica.
La fotografia del fidato Sofian El Fani è molto curata, talora concede qualcosa al formalismo (penso alle scene del parco), ma i corpi e gli amplessi hanno pochi filtri, con tanto di “difetti” e umori e sudori. Ottimo il montaggio: a quanto pare la versione uscita è stata molto rimaneggiata rispetto all’anteprima di Cannes, e si nota l’attenzione riservata al ritmo della pellicola, la cui durata di tre ore non ostacola l’attenzione.
Miglior film del 2013, senza alcun dubbio.
Note:
(1) in questo sono precursori gli iniziali rimandi letterari al libro preferito di Adele: “La vie di Marianne” di Pierre de Marivaux o le passioni sessuali espresse nelle liriche di Francis Ponge, che però la Nostra -distratta- non coglie.
(2) disse Tiresia a Zeus: “il piacere sessuale si compone di dieci parti: l’uomo ne prova solo una e la donna nove”.
(3) romanzo di formazione, ndr.
(4) la pellicola è praticamente priva di campi medi o lunghi: i Maestri Jean-Pierre e Luc Dardenne hanno fatto scuola, e Kechiche ne interpreta peculiarmente la lezione.