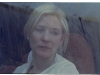Babel è la 3a prova del virtuoso Alejandro González Iñàrritu, giovane regista messicano, già autore di “Amores Perros” e del fortunato “21 grammi”. Il film, presentato quest’anno a Cannes ha vinto il premio per la miglior regia, sfiorando la Palma d’Oro (almeno così dicono le cronache, mentre la palma più ambita è andata a Ken Loach).
Contrariamente al precedente “21 grammi”, Babel convince di più: è sempre un film corale e “ossessivamente” girato (ricchi cambi di macchina, campi lunghi ed impietosi primi piani), che mantiene una cura direi quasi maniacale per la fotografia e l’ormai solito “gioco ad incastri” della sceneggiatura, caratteristica, questa, tipica del regista e del fido sceneggiatore Guillermo Arriaga; qui ancor più accentuata dal meccanismo delle “4 storie parallele”.
Babel è un film internazionale “tout court”, sia nelle location (è ambientato in Messico-Marocco-USA-Giappone), sia nella caratterizzazione dei personaggi (tutti tratteggiati con enorme attenzione e rispetto, privi di qualsiasi immagine stereotipata), sia nell’uso stesso della lingua originale (e qui, per una volta, ho apprezzato la scelta del doppiaggio, limitato esclusivamente agli americani), sia propriamente nelle scelte stilistiche con il quale va a raccontare le 4 storie; ma Babel è soprattutto un film che in questo senso tenta di “gettare un ponte” tra le varie culture e umanità di cui narra, o quantomeno invita a riflettervi, anche se per quanto riguarda la trama specifica non lascia molte speranze.
Le vicende si possono riassumere come segue:
Storia 1: due giovani fratelli marocchini, provando il fucile del padre, feriscono accidentalmente una turista americana e vengono ricercati dalla polizia. Il padre tenta di trarli in salvo.
Storia 2: la turista ferita e il marito vanno in cerca d’aiuto in un villaggio, ma vengono abbandonati dai propri compagni di viaggio dove attendono l’arrivo dei soccorsi (e intanto la questione del ferimento si fa
segue a pag. 9
fa diplomatica, tra paranoie terroristiche ed esagerazioni giornalistiche).
Storia 3: in America, intanto, una tata messicana, cui sono affidati i figli della coppia americana, si deve recare al matrimonio del figlio e non sapendo a chi lasciare i bambini, decide di portarli con sé. Purtroppo al rientro dal Messico vengono fermati dalla polizia di confine e finiscono col darsi alla fuga nel deserto californiano, con tutti i rischi annessi e connessi.
Storia 4: in Giappone un uomo, che durante una battuta di caccia in Marocco regalò il fucile ad una guida (che poi lo vendette al padre dei due ragazzini della storia 1, ammetto che sia un collegamento un po’ forzato), si ritrova a gestire la difficile situazione della figlia adolescente e sordomuta, orfana di madre suicida, la quale, ossessionata dall’idea di essere un mostro, cerca disperatamente un rapporto sessuale.
Il minimo comun denominatore di tutte le storie è il dolore cui sono sottoposti i personaggi e la ricerca, proprio attraverso lo stesso, di una comunanza d’intenti e vicinanza d’affetti che, fino a quel momento non erano tenuti in grande considerazione.
derazione. Peccato che tale comunanza non venga condivisa e che quindi l’occasione d’incontro venga irrimediabilmente sprecata o incompresa.
Uno dei meriti principali di Iñàrritu (oltre a quello di imbruttire Brad Pitt e dargli una parvenza di credibilità) è proprio la modalità con cui sviscera l’umanità dei personaggi e la profondità del dolore; l’abilità con cui passa da situazioni apparentemente lievi ad eccezioni particolarmente forti; la compassione non pietistica con la quale guarda e ci coinvolge nelle disavventure dei suoi uomini / donne / bambini sullo schermo; e la profonda commistione di emozioni contraddittorie che è in grado di evidenziare nei suoi personaggi e suscitare nel pubblico.
Iñàrritu non dà giudizi politici precisi, ma è quasi manicheo nel delineare l’equazione: poveri=felici, ricchi=tristi. Emblematiche in questo senso sono le vicende messicana e marocchina, dove la vicinanza e sincera solidarietà dei primi, in qualche maniera, “punisce” sul piano morale l’egoismo poco verecondo dei secondi.
Ed in questo senso Babel è un film quasi ostinato e “pilotato” nella sua tesi: in un mondo globale l’individualismo non paga.